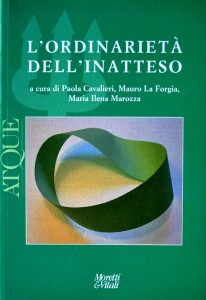a cura di Paola Cavalieri, Mauro La Forgia e Maria Ilena Marozza
PREFAZIONE/Paolo Francesco Pieri/INTRODUZIONE/Paola Cavalieri, Mauro La Forgia, Maria Ilena Marozza/PARTE PRIMA – FILOSOFIA/Enrico Castelli Gattinara, “Piccole grandi cose: fra ordinario e straordinario”/Felice Cimatti, “Quanto fa 25×20? Per una logica del cambiamento psichico”/Graziella Berto, “La cura della singolarità”/Ferdinando G. Menga, “L’inatteso e il sottrarsi dell’evento. Vie d’accesso filosofiche fra domandare e rispondere”/Tonino Griffero, “Alle strette. L’atmosferico tra involontarietà e superattese”/Elena Gigante, “Nòstoi inauditi. Dalla percezione sonora fetale all’ascolto analitico”/PARTE SECONDA – PSICOTERAPIA/Maria Ilena Marozza, “Dove la parola manca il segno. Negli interstizi trasformativi della talking cure”/Mauro La Forgia, “Fenomenologia e clinica dell’ordinario”/Giovanni Foresti, “Esperable uberty. Gli interventi clinici dell’analista come ipotesi di ricerca”/Paola Cavalieri, “Fenomenologia del primo incontro. Vissuti di estraneità e capacità di improvvisare del terapeuta”/Giovanni Stanghellini, Alessandra Ambrosini, “Karl Jaspers. Il progetto di chiarificazione dell’esistenza: alle sorgenti della cura di sé”
- Questo fascicolo di Atque nasce dall’idea di indagare su quelle fasi del lavoro psicoterapeutico nelle quali ci si affida all’esperienza ordinaria, all’immediatezza dei vissuti e dei comportamenti, affrancandosi da forme di lettura dell’altro (e di sé) trasmesse da teorie o tradizioni di riferimento. È nostra convinzione che questi luoghi di indagine abbiano da sempre segretamente caratterizzato ogni psicoterapia; che essi siano stati, e siano ancora, travolti da rappresentazioni e resoconti dogmaticamente fantasiosi di ciò che avviene in una seduta; che, viceversa, una maggiore attenzione a essi, e a ciò che in essi si insinua o si produce, possa costituire la via règia del contatto con quanto di sottilmente pervasivo e nascosto ci attraversa, ci lega agli altri e (nel rapporto con gli altri) ci costituisce.
Riteniamo, in breve, che vada ampliata e posta in primo piano la pratica del sensibile, dell’immediato, dell’”afferrabile” all’interno del dialogo: non ci sono plessi più degni e produttivi di questi per giungere all’individuazione di quanto permea la nostra presenza e le nostre relazioni, evitando ricorsi ideologici o semplicistici all’”inconscio”: riteniamo del resto che non ci sia aspetto più nascosto e inatteso di quello che ci coglie nel quotidiano, “nella nostra stessa dimora”, come pure aveva intuito il Freud più sensibile.
Come è usuale nella tradizione di Atque, la presentazione di queste prospettive terapeutiche avverrà tenendo in mente le loro intersezioni con temi di natura squisitamente filosofica: la centralità del dialogo apre alla semiotica dei codici comunicativi, il tema dell’ordinario, alla complessa definizione di un’esperienza comune, definizione che, a sua volta, conduce al tema dell’incessante ricerca di un mondo condiviso, e alle deviazioni subìte nella realizzazione di una presenza “naturale” che è, insieme, costitutiva e inafferrabile.
Occorrerà quindi, come si è detto, ripartire dai vissuti e dai comportamenti.
Con alcune precisazioni.
L’attenzione ai vissuti non andrà dispersa in una pratica psicologistica convenzionale, di maniera, che dimentichi la natura intenzionale di ogni nostra relazione con cose e persone; il riferimento all’oggetto colloca il vissuto in una ricchezza di prospettive che è pari alle infinite modalità con cui l’oggetto ci si offre; il carattere più intimo e rigoroso di ogni vissuto si esplica nella relazione con un oggetto che, a partire dalle molteplici forme della sua evidenza concreta, assume inevitabilmente qualità trascendentali: nel riprodurre, nel rispecchiare tali qualità. Se poi il vissuto è vissuto dell’altro, la sua intima natura trascendentale, per così dire, si raddoppia, per il semplice fatto che l’altro è un io per sé stesso, un centro relativamente distinto di esperienza vivente: il contatto genera uno spazio radicalmente intersoggettivo che diviene luogo privilegiato di elaborazione di emozioni, di comportamenti, di parole, di pensieri; è finalmente lo spazio dell’esperienza duale immediata, concreta ma in continua trasformazione, che evocavamo poc’anzi come riferimento delle sequenze efficaci del lavoro psicoterapeutico.
Nel comportamento rintracceremo altresì la sorgente reale di quanto è stato per decenni ascritto all’ineffabilità della dimensione inconscia: è esperienza quotidiana riscontrare un’assenza di consapevolezza immediata nella postura, nell’azione, nell’impulso, nella compulsione. O, anche, ritracciare automatismi nel più umano e privilegiato dei comportamenti, quello linguistico: nella variazione dei codici espressivi, nell’uso delle più svariate forme retoriche, nell’assertività come nella logica, nella dissimulazione, nella menzogna, nell’ironia (e quant’altro). Ovviamente, l’inconsapevolezza è relativa all’istante di produzione di ogni comportamento: la coscienza ricostruisce o tenta di ricostruire ex post il senso di quanto prodotto. Ecco qui una simmetria inaspettata tra coscienza e cosiddetto inconscio: la “gestione” di entrambe le dimensioni si affida a una ricostruzione storica di quanto inafferrabile al momento: l’istantaneo è produttivamente oscuro; spetterà all’istante successivo ricostruirlo in un processo incessante di comprensione o spostare la spiegazione all’indietro con un’azione necessariamente ipotetica di ricostruzione del passato.
Ma così come risulterà impensabile una coscienza lucida, piena, di quanto ci attraversa, così come saremo sempre sconfitti, ma risorgenti, nella “padronanza” di noi stessi e del mondo, così sarà irrealizzabile una ricostruzione causale completa dell’esistente in termini di determinazioni passate o segrete.
La valenza produttiva ed etica di ogni psicoterapia (ma anche di ogni esistenza “aperta”) si svolgerà allora nella corretta alternanza tra queste alternative; nell’appercezione della mobile istantaneità di una coscienza sensibile a ciò che “si presenta”, ma anche in una laica e paziente disamina dei presupposti strutturali ed emotivi di quanto ci accade.
- La pratica della talking cure è in fondo un’occasione privilegiata per osservare e modulare quei fenomeni dell’agire linguistico che ordinariamente caratterizzano qualunque relazione umana: non c’è dunque in essa niente di straordinario, se non un’attenzione dedicata a quelle intersezioni, a quegli sfondi, a quelle atmosfere che dimostrano come il nostro parlare non sia semplicemente un fatto comunicativo,
ma un autentico fenomeno vitale. La questione sulla quale ci siamo voluti soffermare va dunque ben oltre la consueta meraviglia sul fatto che le parole possano curare: non è tanto interessante continuare a chiedersi come questo sia possibile, quanto rendersi conto fino in fondo del fatto che nel linguaggio venga a definirsi il modo più specifico e completo di vivere l’esistenza umana. Il che implica che esso non possa essere considerato né come un qualcosa da attraversare per giungere altrove, né come un sistema autosufficiente,
capace di contenere in sé tutte le proprie ragioni: si tratta piuttosto di considerare come il linguaggio sia profondamente innestato in una forma di vita, dalla quale trae alimento in uno scambio aperto e incessante con l’esperienza sensibile.
E dunque, le tematiche che diventano particolarmente interessanti, e che attraversano tutti i saggi raccolti in questo fascicolo, hanno a che vedere con quelle specifiche intersezioni della capacità espressiva e della capacità comunicativa del linguaggio, della paticità e della significazione, nella ricerca di quelle configurazioni dalle quali dipende il senso di ordinarietà delle nostre esperienze. Ecco quindi emergere l’interrogativo sulla capacità del linguaggio di recepire e di curvarsi a esprimere quell’indefinitezza che costituisce il fondo della nostra vita psichica, e che informa la qualità dell’esperienza come un sentimento atmosferico, sfuggente ma altamente influente nell’orientare la ricerca di un riconoscimento rappresentazionale. In fondo proprio su questa vaghezza, invisibile, indefinibile, ma fortemente connotata da un’aria di famiglia, diventa possibile strutturare il senso della nostra domesticità e riconoscere l’appartenza di qualcosa al nostro senso dell’ordinario. Così come, è sempre un sentimento atmosferico, ma qualitativamente connotato dall’estraneità, che inaugura l’esperienza dell’inatteso, allertando la nostra coscienza e provocandola a rispondere a esso.
In questa dinamica tra atmosfere familiari ed estranee possiamo cogliere un nodo essenziale delle riflessioni presentate in questo fascicolo, nonché compiere un passo decisivo nel tentativo di intendere in modo non ideologico alcuni concetti irrinunciabili della teoria psicoanalitica. Quella rappresentazione della soggettività come un io non padrone in casa propria, avvolto, ispirato o insidiato da una presunta dimensione inconscia che, nella sua matrice più profonda, è connotata dall’arappresentazionalità, trova un’espressione più adeguata, ed esperienzialmente più credibile, proprio se ci limitiamo a intenderla come un processo aperto e mai compiuto di soggettivizzazione: un processo che promana da quella zona germinale, di contatto tra “interno” ed “esterno”, tra sé e mondo, in cui prende forma e si rimodula continuamente il confine tra “proprio” ed “estraneo”. In questo senso, sono prevalentemente quegli inattesi, imprevedibili eventi che ci rendono esposti alla provocazione dell’estraneità a costituire il “pungolo” che stimola una nuova apertura e l’inizio di una risposta.
Una fenomenologia che riconosca nel sentimento d’inquietante estraneità – il freudiano Unheimliche – l’operatore soggettivo in grado di attivare una risposta è probabilmente la ricaduta più pregnante, e non ideologica, per quel pensiero psicoanalitico che ha fatto della scissione del soggetto e del funzionamento asimmetrico delle parti la sua principale caratteristica. L’esigenza della teoria psicoanalitica di pensare una dimensione inconscia talmente “altra” da dover essere definita attraverso il pronome neutro es, id o ça, trova una ripresa in quel carattere radicalmente inafferrabile, irrappresentabile, eppure influente, di un’estraneità che, nella forma di un pathos originario, ci colpisce sfidandoci, attraendoci o terrorizzandoci, in ogni caso dislocando ai nostri confini, nella sfida che l’inatteso continuamente propone al nostro senso dell’ordinario, la formazione della nostra soggettività. E, nel sottolineare l’originarietà di una risposta che arriva sempre in ritardo rispetto al turbamento patico, cogliamo ancora una profonda affinità con il dispositivo freudiano della Nachträglichkeit, come mantenimento di una differenza tra l’irriducibilità e l’impossibilità di appropriazione del momento genetico, e la risposta ritardata, rappresentazionale, a esso: una differenza che, se di nuovo ci presenta l’impossibilità di risolvere nel dicibile l’intero campo dell’esperienza umana, ci impegna però nel tentativo di dispiegare in esso le provocazioni dell’estraneità.
Ecco dunque che la nostra talking cure diviene un autentico tentativo di rappresentare e costituire nel linguaggio la complessità della nostra esperienza, per come essa ci si presenta, tra vissuti ordinari ed eventi inattesi: perché, se accettiamo che la connotazione più profonda dell’esperienza abbia a che fare con l’esperienza negativa –
quella cioè che, smentendo le nostre attese, ci confronta radicalmente con l’estraneità – resta comunque alla capacità “terapeutica” del linguaggio il compito di recepire le sue provocazioni, trasformando l’inquietudine che queste ultime introducono nella nostra ordinarietà in una fonte di creatività.
Paola Cavalieri, Mauro La Forgia, Maria Ilena Marozza