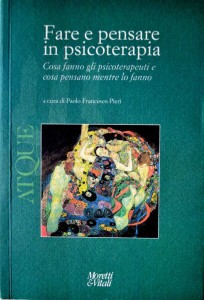a cura di Paolo Francesco Pieri
PARTE PRIMA – PSICOTERAPIA/Giovanni Jervis, “Naturalità e innaturalità delle psicoterapie”/Paolo Francesco Pieri, “La terapia attraverso il linguaggio: dall’approccio analitico a quello simbolico”/Enzo Vittorio Trapanese, “Sfondi della psicoterapia analitica”/Maria Ilena Marozza, “La psicoterapia, l’ironia, l’onestà”/Giovanni Stanghellini, “Per una psicoterapia fenomenologica”/Mauro La Forgia, “L’apparente specificità della clinica”/PARTE SECONDA – FILOSOFIA E SCIENZA/Fabrizio Desideri, “Del comprendere. A partire da Wittgenstein”/Giuseppe Vitiello, “Essere nel mondo: io e il mio doppio”/PARTE TERZA – NEUROSCIENZE/Vittorio Gallese, “I neuroni specchio e l’ipotesi dello sfruttamento neurale: dalla simulazione incarnata alla cognizione sociale”/APPENDICE/Gerardo Botta, “Riflessioni su L’altro maestro”/Gianfranco D’Ingegno, “L’analizzabilità del candidato-analista nel terzo millennio. Una professione in via di estinzione?”/Margherita Vannoni, “La personalità dell’analista come principale strumento del lavoro analitico. Ma quale formazione?”
- Lo psicoterapeuta che intenda definire la propria pratica con l’espressione “psicologia analitica” sta adottando la denominazione che Carl Gustav Jung assegnò nel 1911 parlando di una psicologia delle relazioni tra la coscienza e l’inconscio, e di una psicologia che nel suo darsi è capace di riflettere su se stessa e quindi di ripensare i metodi e le verità che in quella stessa pratica vanno emergendo. Nell’esercizio della sua pratica egli ha certamente acquisito una serie di sensibilità: egli considera che ogni suo processo conoscitivo dell’altro mostra il legame circolare con la conoscenza di se stesso, che ogni conoscenza di sé e dell’altro è positivamente critica non soltanto di sé come parlante ma anche della cultura che gli permette di pronunciare le parole nel senso in cui le dice, e che ogni evento veritativo è non solo in relazione con sé e la sua cultura, ma è impegnativo per lui, che quelle verità esprime.
Un tale psicoterapeuta assume i fatti e gli eventi come cose che si procurano un senso oggettivo attraverso il modello dominante che nell’osservarle e viverle è stato impiegato. Per ciò assume le cose che egli stesso vede, nel loro essere strettamente legate ai modi che la sua tradizione ha man mano incorporato per rappresentarle: vale a dire, considera che anche ciò che dice non riguarda il come stanno veramente le cose che vede, ma riguarda la verità delle cose secondo la prospettiva che si è andata costruendo, una volta installatasi dentro di sé e la propria cultura. È per ciò che il nostro psicoterapeuta non può fare a meno di oggettivare il metodo che di volta in volta impiega.
Egli – molto spesso – ci racconta che fa “naturalmente” riferimento al metodo riduttivo. D’altronde egli non fa fatica a riconosce- re che il principio causale è il “fatto” spirituale che, storicamente e collettivamente, si è venuto a instaurare nella cultura scientifica cui appartiene. Proprio in forza di questo, il nostro ha potuto valutare dall’esterno i prodotti dell’attività mentale di chi gli sta di fronte e sostituirli con concetti elementari. Seguendo il principio del “null’altro che” egli arriva persino a costruire una teoria generale che riguarda
la realtà psichica in se stessa.
L’invito che la formazione in psicologia analitica a questo punto gli rivolge, riguarda il pensare quanto l’istituzione di un senso che non c’era in sé e per sé, ma che è stato introdotto dall’uso del metodo riduttivo, da un lato regali la tranquillità di come stanno veramente le cose, ma dall’altro non faccia che restringere e impoverire la formazione fantastica che ogni volta gli si para dinanzi, e quindi sacrifichi l’abbondanza e la ricchezza di senso, e se vogliamo l’extrarazionalità, che la caratterizza.
Lo psicoterapeuta rammenta, così, che comprendere in modo oggettivo i segni dell’anima somiglia un po’ al comprendere «una cattedrale gotica sotto l’aspetto storico, tecnico e, per ultimo, anche dal punto di vista della mineralogia» (C.G. Jung, Sulla comprensione psicologica di processi patologici (1914), tr. it. in Opere, v. 3°, Torino, p. 188). La sua appartenenza all’ambito di ricerca della psicologia analitica rivolge, infatti, allo psicoterapeuta un appello a costituire forme di conoscenza che solo per metà stiano al servizio dei saperi costituiti, e che, per un’altra metà, gli diano modo di pensare. Le fantasie, i sogni e i deliri che egli ascolta, possono pure, per quanto criticamente, essere spiegati, ma producono saperi che non saturandone il senso, permettono di pensare ancora: nella metafora junghiana, quel che dona «la cattedrale gotica» nella sua «azione vivente», è il rinvio a quella parte che non essendo ancora né nota né familiare attende di essere conosciuta.
- In questa prospettiva, lo psicoterapeuta sa di non possedere una conoscenza dell’inconscio in sé, ma può attribuire comunque all’inconscio una condizione della coscienza per la quale ogni sua conoscenza e ogni suo sapere ci sia effettivamente. Egli assume quindi l’inconscio come fondo e sfondo polisemico delle figure di senso, e quindi come ciò che sta lì a fondare i significati cognitivi e affettivi di cui lui e la persona che lavora con lui dispongono.
L’inconscio diventa così ciò che produce e mantiene vivo l’ordine del significare, e nello stesso tempo – ma da un altro punto di vista – ciò che consente la bontà del funzionamento del proprio e dell’altrui sistema psichico generale. Per ciò egli tiene conto che l’azione della coscienza, come una struttura che riferisce all’Io i contenuti psichici, è sempre relativa, ed è sempre in relazione, ad un’attività psichica inconscia che quasi la precede e che, proprio per il suo continuo funzionare, la permette: minacciandone però la stabilità quando la coscienza stessa non la riconoscesse come tale.
Lo psicoterapeuta junghiano, criticamente avvertito, ha nella sua “cassetta degli attrezzi” un’idea d’inconscio né assoluto né perfetto, né statico né atemporale, bensì relativo e imperfetto, dinamico e dinamicamente legato alla temporalità: vale a dire l’immagine di un inconscio come parte del complessivo sistema psichico che funziona in accordo con le altre parti. Egli sa, in particolare, che eventuali forme attribuite all’inconscio non valgono per sempre: le specifiche forme che assegna all’inconscio sono ogni volta designazioni eccedenti la coscienza e – in relazione a questa – opposte e complementari (C.G. Jung, La struttura dell’anima (1927/1931), tr. it. in Opere, v. 8°, Boringhieri, Torino, p. 167). Oltre all’idea di un inconscio che condiziona storicamente la coscienza del singolo individuo, ma anche naturalmente e collettivamente la coscienza dello stesso individuo come soggetto propriamente umano, un tale psicoterapeuta ha nella sua cassetta degli attrezzi un’idea d’inconscio che svolge un’impalpabile quanto “invisibile” condizione che corre parallela all’altra di cui si diceva (Ivi, pp.174-176), e che produce l’innovazione della conoscenza in atto, e quindi una nuova attribuzione di senso al mondo, alle cose e alle persone.
Egli può, infatti, ipotizzare un’azione creativa dell’inconscio, e quindi una creatività che non essendo nelle mani dell’Io è condizionata dall’immaginazione inconscia e, per questa via, da una funzione mitopoietica che viene a darsi in modo vincolante sia a livello individuale che a livello collettivo (Cfr. prima stesura di Simboli della trasformazione: C.G. Jung, Wandlungen und Symbole der Libido, in «Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen», 3, 1911; 4, 1912). Questo psicoterapeuta può cautamente fare ricorso all’idea di una causa creativa inconscia che avviene nello psichico, ma attraverso una serie di vincoli. Questi sono: da un lato, il “combinarsi” degli elementi ma anche delle funzioni e degli atteggiamenti psichici fondamentali (si pensi alle teorie dei complessi, dei tipi e degli archetipi); dall’altro lato, l’”evolversi” di quella materia prima che è la libido, come processo psichico che dà luogo a transizioni tra i diversi codici simbolici come emblemi delle rappresentazioni cognitive e affettive che l’uomo ha di sé e del mondo.
- Un simile psicoterapeuta svolge un vero e proprio lavoro analitico che ha il fine di ricercare sia le cause della sofferenza psichica, sia i significati profondi dei sintomi psicopatologici, sia le differenti relazioni in cui sussistono i componenti ultimi dello psichico: un procedimento volto alla descrizione, interpretazione e comprensione di tali oggetti secondo i componenti più semplici e le differenti relazioni che intercorrono tra loro. In questo senso egli svolge un’analisi che è letteralmente un procedimento scompositivo e, come tale, una ricerca di componenti elementari.
Egli sa bene che la ricerca di tali elementi fondamentali non può arrestarsi lì, perché conduce a un’altra che invece è volta a produrre una loro nuova composizione. Egli però sa altrettanto bene che ogni verità analitica che egli possa pronunciare è una penultima verità, perché solo per il suo darsi effettivamente all’interno del dialogo psicologico essa è suscettibile d’ulteriore – propria o altrui – rettificazione o correzione (M. Trevi, Il lavoro psicoterapeutico. Limiti e controversie, Roma-Napoli 1993).
Come si è detto, lo psicoterapeuta che intende definire la propria pratica con l’espressione “psicologia analitica” sa bene che sta adottando la denominazione che Carl Gustav Jung assegnò nel 1911 parlando di una psicologia delle relazioni tra la coscienza e l’inconscio, e di una psicologia che nel suo darsi è capace di riflettere su se stessa e quindi di ripensare i metodi e le verità che in quella stessa pratica vanno emergendo.
Un tale psicoterapeuta, sull’altro versante della sua pratica, sa altrettanto bene che il paziente, non disponendo di una coscienza trasparente (di una coscienza pensabile non già vicina a sé bensì non pienamente capace di controllo su se stessa se non addirittura scissa) finisce con il ridisegnare i modi attraverso cui la sua individualità e i relativi rapporti gnoseologici e affettivi con sé e con il proprio mondo, vengono di volta in volta a costituirsi.
- Per tale psicoterapeuta la realtà di cui il paziente parla è quella che è divenuta tale nella sua mente – con le esperienze che il paziente stesso ne ha fatto e con le interpretazioni che ne ha dato. Le persone delle quali il paziente racconta spesso e con grande vivacità le storie, lo psicoterapeuta non le assume, infatti, in sé e per sé bensì come entità e vicissitudini che per lui sono vive e reali perché si sono intrecciate alla sua sfera psichica. Il suo rappresentare (e rappresentarsi), per esempio, le persone in un modo o in altro, rinvia a un evento di tipo gnoseologico e affettivo, che è accaduto sulla quota del suo psichico: di rimbalzo all’incontro con i suoi molteplici complessi psichici, si sono date differenti immagini delle persone stesse, e si è dato pure che una delle immagini prodotte nella sua mente ha vinto sulle altre. Essa è l’affermazione, magari fortunata, di un certo punto di vista su gli altri che variamente si agitano e interagiscono per così dire nel suo psichico: nell’adattamento reciproco tra lui come persona e il mondo che egli abita, si è venuta ad attuare una necessaria ed efficace scelta e “restrizione” dei molteplici significati e delle differenti immagini assegnabili per l’appunto allo stesso mondo del quale il paziente ci narra.
D’altronde il nostro psicoterapeuta sa che è proprio Jung a contribuire alla costruzione di una psicologia della conoscenza dove la realtà non esiste senza che la persona ne abbia una specifica rappresentazione, e dove la conoscenza è non già un semplice prodotto della ragione, bensì è piena d’immaginazione. La ragione, nel suo essere effetto di pensiero e affetto, è divenuta con Jung un “pensiero immaginato”, e ciò perché – sul solco di Jung – la realtà è conoscibile solo attraverso un contatto psichicizzato, che poi diventa una “memoria sognante” o – con tutta una serie di differenze – quella che Freud chiamava “attenzione fluttuante”.
Se la realtà esiste solo nella nostra rappresentazione e quindi ha bisogno di noi, per un altro verso la realtà non si esaurisce nella rappresentazione che ogni volta ne diamo: perché essa è proprio ciò che è altro da noi. Con il termine realtà il nostro psicoterapeuta intende pertanto ciò che per esistere davvero ha bisogno non già degli interventi dell’Io, bensì della sua sorpresa, e quindi dell’impegno del nostro insieme psichico: la realtà non è ciò che sta tout court di fronte all’Io, ma è ciò in cui siamo immersi e con cui la nostra complessità psichica si cimenta; alla realtà possiamo pure strappare i veli delle nostre illusioni, i veli delle nostre “proiezioni” e delle nostre “identificazioni”, ma non possiamo svelarla (C.G. Jung, La struttura dell’anima, cit.).
È proprio dall’idea di una funzione simbolica che consente alla libido umana come energia in-formativa di costituire forme diverse del reale, che Carl Gustav Jung, sin dal 1911, ammette che ciò che ogni volta è in gioco nella psicologia è non già il reale in sé e per sé, bensì il reale che di volta in volta si raffigura e si configura, e non semplicemente traspare in modo definitivo, nei nostri linguaggi e nei nostri pensieri. Rinviando la trattazione di quest’articolata questione, s’intende per ora porre l’accento sul fatto che il nostro psicoterapeuta ha in mente le due questioni che Jung ne fa derivare: per un verso, quella per cui lo psichico della persona in terapia non è mai raggiungibile né direttamente né indirettamente, ma coincide con quelle forme simboliche che il suo movimento cognitivo e, insieme, affettivo assume e dispiega nel quotidiano scambio col mondo e quindi nella stessa terapia, e per un altro verso, quella per cui lo psicoterapeuta, volendo fare qualcosa di psicologico con quel paziente e quindi intendendo non venire fuori da quella relazione terapeutica, usa – ma solo criticamente – l’approccio analitico dove vigono i criteri della distinzione e della riduzione, ma sta – fondamentalmente e innanzitutto – dentro un approccio simbolico dove vigono invece i criteri dell’integrazione e della costruzione.
Essendo necessaria per la costituzione della realtà, un’esperienza che è l’effetto di differenti modi rappresentativi e percettivi, affettivi e sensoriali, lo psichico del paziente appare al suo psicoterapeuta come un ordito, misterioso e ignoto, di varie forme di significati e di molteplici eventi a carattere interpretativo: dove per l’effetto di una restrizione della molteplice, se non infinita, possibilità interpretativa degli oggetti, di questi si formano certe immagini consce e vigenti, e altre inconsce ma altrettanto “in corso”. La vita mentale del suo paziente gli appare, così, costituita dalle molteplici immagini in cui di volta in volta si dispiega, e non già da eventi esatti e direttamente descrivibili, e quindi lo assume come un indeterminato e indeterminabile
insieme, costituito dall’interazione dei molteplici flussi gnoseologici e affettivi che ogni volta esprimono le differenti ricostruzioni, e quindi le diverse rappresentazioni della realtà.
- Nella tradizione cui il nostro psicoterapeuta appartiene, c’è sapere là dove s’installa una conoscenza, e quindi là dove si costituisce un’interpretazione che permette di operare una “restrizione” e quindi una “riduzione” dei molteplici se non degli infiniti significati che alle cose e alle persone possono essere attribuiti. E, di contro, c’è pensare là dove, riaprendosi tutto questo, si rende possibile un’innovazione dello stesso sapere.
Emerge così nella mente dello psicoterapeuta che l’intelligenza razionale è la facoltà analitica che scompone l’esperienza in idee e concetti, ma che questa costituisce soltanto una fase del processo cognitivo e affettivo, e per ciò ha continuamente da dissodare i suoi effetti, per entrare in un’altra, che poi è quella della vita. In altri termini, come la vita di ciascuna persona, così la vita in ogni ambito dei saperi si articola attraverso un momento in cui si acquisisce una conoscenza, che nella sua limitazione intellettuale e quindi nella sua definizione e restrizione di senso, può essere chiaramente verbalizzata e comodamente comunicata, ma anche attraverso un altro momento in cui accade la possibilità di mettere in discussione e ripensare tutto questo.
Nella prima fase – che non abbisogna di elaborazioni – nasce e si esercita il sapere, razionale e logico, che distingue la persona con le sue “intenzioni” da una parte e le sue “rappresentazioni degli oggetti” dall’altra. Nella seconda fase, invece, nasce e si esercita lo sguardo del pensiero, libero e fluttuante, che connette uomo e mondo: la persona spogliata delle sue stabilizzate intenzioni e il mondo spogliato a sua volta delle sue cristallizzate rappresentazioni. È così che una persona è restituita al suo rapporto originario con il mondo, e che tra la persona e il mondo nasce una quasi unità – che come tale fa segno al loro preesistere in un’originaria “in-distinzione”. È per l’effetto di questa seconda fase sulla prima, che ogni sapere assume un carattere che approssimativamente possiamo chiamare “empirico”: è – ogni volta – un comprendere ciò di cui si fa esperienza, che non equivale – mai – a spiegazioni esterne, definitive e assolute. (Il sapere è da assumere come la comprensione dell’esperienza, e quindi come un’interpretazione, ed essenzialmente come un evento simbolico. Ciascun sapere rispetto a qualcosa che c’è in quanto si sperimenta, equivale un po’ a un pensiero che perviene a un’espressione stabile, e quindi è un’interazione che non autorizza a chiudere definitivamente né il pensare né l’esperienza. In altre parole ancora, Il pensiero che nel sapere si esprime, è piuttosto il costituirsi, provvisorio, di un’in-differenza tra pensare ed esperire, e quindi è una risposta che dicendo di corrispondere all’esperienza non può, e non potrà, non essere ripensata.)
- Per questa via, si sviluppa ancor più l’ipotesi che ogni istituzione – scientifica ma anche quotidiana – del pensare, è un sapere fondato su una restrizione che accade al pensiero e alla fantasia, per un’esigenza pragmatica, strettamente enunciativa e comunicativa.
È attraverso una tale teoria, che si prepara una psicologia della conoscenza della realtà in cui questa non esiste senza che la persona umana ne abbia una specifica rappresentazione, e in cui la conoscenza è non già un semplice prodotto della ragione, bensì è piena d’immaginazione e affetti.
Proprio per l’intrecciarsi del pensiero con l’affetto, la ragione è quello che si dice un “pensiero immaginato”, e la realtà è ciò che è assolutamente distante e diverso da noi ma che per essere conoscibile ha bisogno di un contatto psichico, di una “memoria sognante” (dream like memory) o di quella che già Freud chiamava “attenzione fluttuante”: la realtà ha bisogno di noi, ma non esaurendosi nella rappresentazione che noi ogni volta ne diamo nella nostra mente, è proprio ciò che è altro da noi.
Con realtà si viene a inyendere, lo ripeto, ciò che per esistere veramente ha bisogno non già degli “interventi” dell’Io bensì della sua “sorpresa”, e quindi dell’impegno dell’intero nostro insieme psichico. La realtà non è ciò che sta immediatamente di fronte all’io, ma è ciò in cui l’io si trova immerso e con cui la complessità delle rappresentazioni psichiche, si cimenta – d’altronde, alla realtà in sé e per sé potremo pure strappare i veli delle nostre illusioni, delle nostre “proiezioni” e delle nostre “identificazioni”, ma non potremo mai svelarla.
Da ciò emerge piuttosto che nel parlare di realtà si assiste ogni volta all’intreccio di due classi d’oggetti che occorre tenere costantemente, seppure in vari modi e per vari gradi, distinti. C’è un oggetto della realtà che è l’insieme delle cose e dei processi esterni alla conoscenza, di cui per l’appunto si conoscono le funzioni, le strutture e le relative evoluzioni. C’è inoltre un oggetto della conoscenza che è ciò che, essendo interno alla stessa conoscenza, esprime e permette di ricostruire il linguaggio e la struttura, logica e concettuale, dello specifico sistema teorico, individuale e collettivo, che traducendo o sublimando l’oggetto della realtà ne dà una specifica “rappresentazione”.
L’introduzione delle due classi d’oggetti tenta di rendere conto sia dell’innovazione di senso che nella vita si può elaborare, sia del modo innovativo di afferrare lo psichico sul piano della ricerca – oltrepassando l’ingenua “unilateralità” e l’acritico dogmatismo delle “prese” della realtà, che compie la scienza, così come quotidianamente si comporta la coscienza.
Per il nostro psicoterapeuta, la conoscenza assume per tale via un po’ il movimento di un pendolo che disegna un arco ben preciso.
C’è un momento di chiusura, dove l’”oggetto della realtà” mostra di coincidere analogicamente con quello della conoscenza. Di questo momento fanno parte l’”oggettività” e l’”intersoggettività”, dove l’oggetto della realtà guadagna una provvisoria indipendenza dal processo della conoscenza, consentendo una pausa al pensiero individuale e collettivo, e insieme il costituirsi di un sapere sul piano della coscienza. C’è, poi, un momento d’apertura, dove l’”oggetto della realtà” evidenziando invece la sua irriducibile differenza rispetto all’”oggetto della conoscenza”, mostra la possibilità di assumere un nuovo rivestimento di significato. Fa parte di quest’altro momento la distinzione tra ciò a cui noi pensiamo e ciò che di questo pensiamo: una distinzione che inaugurando una temporanea sospensione della conoscenza già costruita, dà vita ad un “mondo intermedio” della simbolizzazione, fatto di differenti soglie di realtà, dove il “principio di realtà” non è un “rispecchiamento” della realtà, e dove il “principio di piacere” non è ancora (o non è più) “immaginazione” priva di realtà. In questa, che è una fase d’elaborazione, c’è in ogni modo la morte, e il relativo lutto, delle cose che si sentono e si conoscono nel loro – già dato – rivestimento cognitivo e affettivo. È per ciò che la vita, proprio nel doppio versante cognitivo e affettivo, ricomincia – ogni volta – con la sensazione di un vestito stretto: con un ovvio che c’è ancora, ma già indica qualcosa che non conosciamo. È in questi particolari momenti che ci accorgiamo veramente di noi stessi e degli altri; e, accorgendocene, ci scopriamo già ingaggiati in un gioco che non ha niente a che fare con la routine: in un’auto-individuazione che, essendo un flusso vivo di pensieri ed emozioni, obbliga a gettare un altro sguardo su noi e sul mondo consegnando entrambi a una seconda nascita cognitiva e affettiva […].
Paolo Francesco Pieri