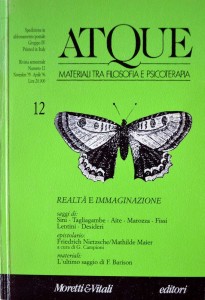NOTA EDITORIALE/Carlo Sini, “Realtà e immaginazione”/Silvano Tagliagambe, “Creatività”/PaoloAite, “La visibilità da conquistare: note sull’immaginazione in analisi”/Maria Ilena Marozza, “L’immaginazione: all’origine della realtà psichica”/Stefano Fissi, “I molti e l’uno in alchimia: l’imaginatio come luogo di integrazione di confusità della materia psichica”/Luigi Lentini, “Immagine metodologica e ‘realtà’ scientifica sulla teoria anarchica della conoscenza”/Fabrizio Desideri, “Al limite del rappresentare: nota su immaginazione e coscienza”/Ferdinando Barison, “Risposta ‘originale’: vetta emeneutica del Rorschach”/MATERIALI/Giuliano Campioni, “La difesa dell’illusione metafisica: una ‘wagneriana’ [M. Maier] risponde a Friedrich Nietzsche”
La realtà e l’immaginazione ci sono veramente, laddove sussiste una differenza che vive insieme a loro: e cioè, proprio esistendo una specifica differenza, non si dà problema sia nel riconoscere “ciò che c’è” (e quindi è esistente o reale) e “ciò che non c’è” (e quindi è inesistente o immaginato), sia nell’ammettere che certe cose immaginate non sono sempre reali e che certe altre cose, per quanto siano reali, non sono sempre immaginabili. Il carattere in cui differiscono il reale el’immaginario, rinvia pertanto a una differenza di tipo interpretativo: per esempio, una attribuzione di qualità materiale alla “realtà” e una attribuzione complementare di qualità psichica all’”immaginazione” sussistono relativamente al persistere di quella differenza teorematicache si suole far risalire a Cartesio, per cui – proprio compiendo simili attribuzioni – noi facciamo rivivere quella differenza che era già postadal pensiero cartesiano. Sicché tali attribuzioni non sono di per sé asserzioni di verità, in quanto tali enunciati rappresenterebbero la nostraappartenenza, viva e vera, a quella specifica pratica dualistica che fu tradizionalmente cartesiana. Deriva comunque un comportamento anti-etico laddove volessimo passare spensieratamente dall’esercizio di una pratica a un’altra: e cioè senza enunciare rigorosamente i relativi presupposti. Per esempio: nell’ambito della sofferenza cosiddetta “mentale”, non si può parlare della malinconia dopo aver parlato delle sinapsi, senza prima avere enunciato sia tutto il sapere psicologicoda cui discende l’oggetto “malinconia”, sia tutto il sapere neurologico da cui discendono quegli altri oggetti che chiamiamo “sinapsi”ripensando veramente tutte quelle differenze che hanno istituito ledue differenti forme di sapere, e cioè le loro conoscenze o i loro dati, e i loro errori o le loro illusioni. Se del problema che precede, si occupa il saggio di Carlo Sini, il passaggio da una forma di sapere già data a un’altra che invece non è ancora data, è svolto dal saggio di Silvano Tagliagambe. A questo fine viene introdotta la nozione di creatività simbolica che, restando pericolosamente in bilico tra la realtà e l’immaginazione, attiene ai fondamenti sia dell’arte che della scienza, oltreché delle nostre pratiche quotidiane. Della medesima difficile questione, seppure dalla prospettiva della psicologia analitica junghiana, si occupano, in vari modi, i saggi di Paolo Aite, Maria llena Marozza e Stefano Fissi.
Da Paolo Aite viene in particolare introdotta la nozione di immagine come tramite tra mondo e psiche, per cui essa è fondamentalmente intesa come disposizione a vedere in un certo modo. Sicché viene considerato il fatto secondo cui, laddove sia raggiunta una nuova visione dello stesso oggetto, l’immagine stessa provocherà contemporaneamente una modifica della situazione psichica soggettiva. In questo senso, l’analisi è considerata come il campo in cui vengono ricercate le immagini delle cose più che i loro nomi – non potendo quest’ultimi rappresentare appropriatamente il movimento emotivo con cui il soggetto si intrattiene con quelle. Le immagini e, in un certo senso, gli stessi nomi non sono pertanto considerati come un mero segno delle cose interne o esterne bensì come simboli che, nel rivestire le cose del mondo esterno e di quello interno, le mettono contemporaneamente in azione. Nomi e cose accadrebbero attraverso il linguaggio – laddove il linguaggio è però assunto nella sua funzione simbolizzatrice: e cioè nella sua funzione di rivelamento e nello stesso tempo di rinvio a un qualcos’ altro non ancora conosciuto ma che si vuole comunque conoscere.
Da Maria llena Marozza viene invece introdotta la nozione di immaginazione così come è stata veicolata dal pensiero junghiano. Per un verso, l’immaginazione è specificamente intesa come una possibilità di significare: e cioè come un significare che proprio nel suo andare oltre il convenzionale si mostra come concreta e specifica irripetibilità dell’esperienza individuale. Per un altro verso, l’immaginazione assume il carattere di una prima messa in forma del pensiero, per cui risulta essenzialmente intesa nella sua finalità di regalare al pensiero la possibilità di pensare veramente. In quanto ancora legata inestricabilmente alla sensibilità e alla passione, l’immaginazione rinvierebbe ìnfatti a un luogo e un tempo in cui uomo e mondo sussistono in uno stato di identità o di blocco. Nell’essere la stessa cosa, e quindi nel loro ritornare all’originaria indistinzione, l’uomo e il mondo possono darsi attraverso una distinzione differente rispetto a quella precedentemente data, per cui il blocco cosiddetto “nevrotico” può assurgere a emblema di una finalità creativa, e, per l’appunto, recare la possibilità di nuove rappresentazioni cognitivo-affettive sia di sé che del mondo. In altri termini, l’immaginazione non è colta nel suo volgere le spalle alla realtà bensì è colta proprio nel suo rivolgersi a quest’ultima cogliendola come un elemento a cui essa è stata contrapposta e risulta, proprio attraverso questa relazione oppositiva, ad essa costantemente rinviante.
Le nozioni di immagine e di realtà entrano per un altro verso a far parte anche del saggio di Luigi Lentini. Che della scienza si dia un’immagine metodologica fuorviante rispetto a quella anarchica, che invece sarebbe proprio quella più vera e reale, è ciò che problematizza il saggio incentrato sull’anarchia epistemologica proposta da P .K. Feyerabend. Come sappiamo il suo presupposto consiste nell’importanza primariamente assegnata alla libertà e all’indipendenza degli uomini e alla loro possibilità, per così dire, di godersi la vita. Sappiamo quante volte questo originale pensatore della storia del pensiero scientifico avesse cercato di descrivere come edonistica la sua posizione teorica: e cioè quanto egli abbia voluto pensare le costruzioni della scienza e le istituzioni di quest’ultima attraverso quella dottrina filosofica che intende come unico bene possibile e quindi come fondamento della vita e della stessa vita scientifica, il piacere. Sicché egli misurò il valore della scienza in base al piacere che essa fosse capace di arrecare ai suoi professionisti, seppure la scienza – come ogni ideologia e religione – ami invece mostrarsi se non come un modello di perfezione, almeno come modello migliore e sempre migliorabile. Analogamente alle ideologie e alle religioni, la scienza è intesa come un insieme complesso di modelli che ogni uomo può accettare ma anche rifiutare e ciò a seconda delle personali inclinazioni: tale insieme non sarebbe però rifiutabile da colui che ambisca a partecipare alle istituzioni scientifiche. Colui che chiede un istruzione e un addestramento istituzionalizzati dovrà infatti rinunciare alle proprie inclinazioni personali altrimenti riceverà l’ostracismo e sarà considerato «non scientifico» proprio da parte di quella comunità scientifica cui desidera afferire.
Il saggio di Fabrizio Desideri problematizza quella che è stata una delle teorie più originali che sull’immaginazione abbia saputo produrreil pensiero della prima metà del nostro secolo: e cioè quella teoria sull’immaginazione che J.-P. Sartre in più riprese elaborò in riferimento alla fenomenologia husserliana. Partendo dalla lezione sartriana sull’immaginazione come esercizio di un potere «irrealizzante» nei confronti delle cose per cui la coscienza si manifesta nella sua capacità di trascendere l’ordine già dato del mondo, viene infatti approfondito il tema del processo tappresentativo e dei suoi esiti, di rimbalzo, anche su quello specifico oggetto che è il Sé.
Il saggio di Ferdinando Barison era stato pensato per il prossimo fascicolo di «Atque» dedicato allo stato della Psicopatologia. La sua pubblicazione viene qui anticipata non soltanto perché il carattere creativo dell’immaginazione che esso sviluppa, inerisce strettamente alle questioni del presente fascicolo ma anche per onorare la memoria di questo psichiatra e psicopatologo la cui recente scomparsa ha lasciato un lutto difficilmente elaborabile da parte di quella psichiatria che sa di non potere escludere dal pensiero ciò che quotidianamente fa. Con questo, che è l’ultimo scritto di Barison, il lettore viene concretamente introdotto nella pratica quotidiana di uno psicologo o di uno psichiatra che incontri il paziente attraverso il test di Rorschach.
Quest’ultimo, liberato dalle sterili controversie sulla sua validità obiettiva, viene fondamentalmente inteso come un’occasione che reca con sé momenti interpretativi e reinterpretativi attraverso cui si possono dare nuove immagini del mondo e, contemporaneamente, dell’uomo. Pertanto ogni interpretazione delle cosiddette “macchie” da parte del “paziente” – e cioè la sua lettura delle tavole che rappresentano oggetti «annichiliti» della loro realtà e, nello stesso tempo, pregni di significato – viene a sua volta interpretata dallo psicologo o psichiatra, e insieme a questo costante rinvio interpretativo, si potrà osservare come si vengono a costituire singolari momenti originanti nuove immagini del soggetto e dell’oggetto.
Chiude il fascicolo un denso seppure breve scambio di lettere tra Friedrich Nietzsche e Mathilde Maier. Molti saranno i modi di lettura di questo epistolario curato e introdotto da Giuliano Campioni, qui si vuole soltanto sottolineare il carattere emblematico che esso può rivestire: e cioè il suo essere l’esempio di un conflitto attraverso cui si dà vita alla realtà e all’immaginazione. Rileggendo l’evento di una nuova interpretazione carica di possibilità trasformative di una realtà già data in una nuova realtà, o di un vecchio in un nuovo errore, si potrà – quasi dal vivo – osservare le dinamiche tra la vecchia e la nuova interpretazione quali contendenti (distinti e opposti), e la sofferenza di coloro che in quelle si identificano.
Nel fascicolo sono in vari modi introdotti il tema dell’alchimia e il rapporto di quest’ultima con la psicologia analitica. Per una riflessione sui problemi di una tale inserzione, si rende quindi necessaria una chiarificazione di tipo terminologico. A partire da una visione del reale in cui la materia e lo spirito ma anche l’uomo e il mondo rivelano legami profondi, l’alchimia designa un insieme di operazioni in cui si trovano ricomposti gli atteggiamenti pratici e quelli teoretici, gli aspetti artigianali e quelli simbolici. Proprio perciò l’alchimia è stata intesa da C. G. Jung come una disciplina teorica e pratica che presupponendo corrispondenze, affinità e influssi tra i differenti componenti visibili e invisibili del cosmo, propone – attraverso complesse operazioni ma anche attraverso colui che compie tali operazioni –, sia di trasformare i metalli «vili» in metalli «nobili», sia di condurre l’ operatore stesso verso condizioni di umanità «nobile» o «aurea», ma ciò proprio a partire dalle condizioni di umanità «impura» in cui si trova.
Nel linguaggio alchemico, il termine «trasformazione» indica fondamentalmente il processo della costruzione del reale: e cioè il pervenire alla pienezza della essenza segreta delle cose, liberando quest’ultime dalle impurità e dalla corruttibilità: e cioè con la trasformazione di ogni metallo nel metallo per eccellenza e di ogni uomo nell’uomo per eccellenza. E quindi con la preparazione di un «elisir di lunga vita», l’alchimia e l’alchimista si rivolgerebbero insieme a produrre essenzialmente quell’evento particolare e «segreto» che è l’opera nella sua «perfezione», ossia l’opera nel suo compimento o realizzazione completa. In quanto rappresenta un aderire all’opera nel suo reale ed effettivo compiersi, tale evento è considerato il «trionfo» dell’operatoree dell’opera ed è chiamato «pietra filosofale». Quest’ultimaespressione che viene rigorosamente distinta dalla «pietra dei filosofi» con cui è invece indicata la materia dell’opera alchemica, apre alla considerazione del fatto che proprio nell’opera e attraverso di essa vengono a porsi i fondamenti della conoscenza e quindi a ritrovarsi concretamente quei saperi che nelle pratiche precedenti erano stati stituiti e quindi “pietrificati”.
Al di là dell’analisi storica che Jung ha saputo produrre intorno alle diverse forme in cui l’alchimia è stata presente nelle tradizioni orientali ed occidentali, i lavori junghiani dal1928 in poi, contengono di frequente una ricerca che si potrebbe definire di tipo psico-storico, intorno alle questioni centrali di cui si è occupata la disciplina. Tali lavori sono rivolti soprattutto a confermare e ampliare l’ipotesi dell’immaginario collettivo e i suoi simbolismi, ed a riflettere sulla teoria della pratica clinica e quindi sulle nozioni di transfert e di controtransfert. In particolare, in quell’opera dell’alchimista che è tesa alla fabbricazione dell’oro partendo dai metalli più vili, Jung individua la metafora di quell’operare psicologico rivolto a dare essenzialmente forma alle forze immaginative dell’uomo. E come l’alchimia avverte l’annidarsi dell”’oro” proprio nei “metalli più vili”, – cogliendovi, per analogia, la presenza di espressioni spirituali più elevate (o, meglio, superiori a quelle che a livello razionale si intendeva che vi fossero contenute) –, così ai contenuti dell’immaginario che nel processo psicologico traspaiono nella coscienza (e che da quest’ultima sono considerati negativi), la psicologia analitica attribuisce la possibilità di produrre un particolare ampliamento della coscienza stessa, a patto che l’uomo psicologico moderno (come allora l’alchimista), non rendendosi passivo strumento di queste spinte immaginative inconsce, sappia restarvi eticamente davanti come un “operatore” consapevole e responsabile.
Più in particolare, Jung costituì due precisi parallelismi tra alchimia e psicologia analitica: e precisamente intese la trasformazione alchemica come l’emblema della trasformazione psicologica e considerò l’opera alchemica che si rivolgeva alla «pietra filosofale» attraverso la ricognizione e l’uso della «pietra dei filosofi», come il modello del processo di individuazione rivolto alla ricerca del Sé – proprio attraverso la ricognizione dei differenti complessi immaginativi.
Insieme a queste due considerazioni, l’alchimia ricevette da Jung una precisa interpretazione, e cioè venne addotta come conferma della sua dottrina degli archetipi. In questo senso, il linguaggio dell’alchimia è inteso come nient’altro che un emblema delle modalità attraverso cui, sul piano collettivo, riaffiorano le immagini degli archetipi. Sicché, da un lato, l’immaginario alchemico è assunto a esempio di quelle che Jung stesso definisce come strutture profonde e costanti dell’immaginazione umana, e, dall’altro, l’opera alchemica che si attua attraverso quel particolare linguaggio degli alchimisti, viene a rappresentare una ricognizione sistematica degli strati profondi dell’immaginazione. Secondo queste argomentazioni, il termine junghiano che è poi divenuto centrale è quello di «immaginario» per cui più che guardare all’immaginazione come a una delle facoltà dell’uomo di rappresentarsi le cose non attualmente date, si volge lo sguardo verso quelli che sono stati i suoi prodotti e quindi verso l’infinito repertorio dei miti e dei simboli – cogliendo le strutture differenziali che sono ad essi interne. Tale ricognizione dell’immaginario non va però considerata in sé e per sé, essa va semmai colta nel suo stesso accadere, e quindi in quanto opera della stessa immaginazione.
Dell’azione dell’immaginazione nel suo rivolgersi all’immaginario come luogo originario, sono state propriamente colte tre finalità: la rigenerazione di quella specifica parte psichica che è l’Io, e più in generale la restituzione di ogni singola parte della psiche a quel tutto che è l’universalmente umano, ma – insieme a questo– il rinvio di ogni prodotto della psiche al processo simbolico-individuativo che è tipico dell’uomo. Detto in altre parole, l’alchimia permise a Jung di approfondire e riformulare una serie di concetti come quelli di coscienza, esperienza e reale. La lettura dell’alchimia, assunta nei suoi innesti con la teoria della conoscenza e la dottrina dell’immaginazione e dell’immaginario, introduce infatti nel pensiero di Jung una maggiore consapevolezza di tipo epistemologico. Pertanto, non più escluso come già era avvenuto presso molti pensatori e in diverse epoche a causa dell’idea che potesse veicolare strane fantasie, ma neanche esaltato soltanto per queste, e neppure considerato come una mera preistoria della chimica moderna, il magistero alchemico è inteso essenzialmente come il portatore di una implicita modalità di rapporti gnoseologici e pratici tra uomo e cosmo – molto più promettente rispetto alle ingenuità già osservate nel positivismo della psicologia di allora. Proprio con queste caratteristiche l’alchimia può, forse, ancora oggi produrre una serie di esiti critici sul piano dei fondamenti sia della scienza psicologica che del trattamento analitico.
Paolo Francesco Pieri